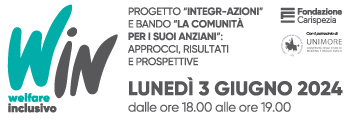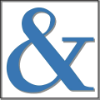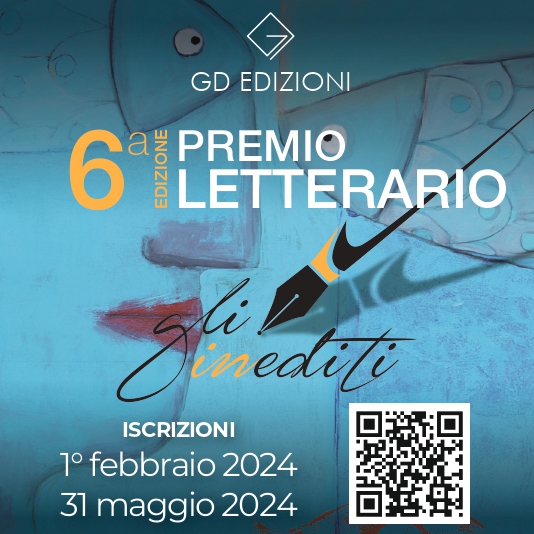Il 10 maggio 2010, nella Sala della Provincia della Spezia, su invito di Pino Ricciardi e Marcello Delfino, animatori del Circolo “Pietro Scoppola”, ho avuto l’onore di presentare il libro di padre Bartolomeo Sorge La traversata-La Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi, edito nello stesso anno da Mondadori. Ho piacere di ricordare padre Sorge, a poche ore dalla scomparsa, riprendendo il mio contributo con il quale si avviò lo speciale pomeriggio spezzino di cui fu protagonista l’autorevole padre gesuita. Padre Sorge ritornò alla Spezia il 15 maggio 2011 per svolgere la lectio magistralis sul tema Bene comune, etica, legalità nella giornata conclusiva di Parole di giustizia.
L’interessante libro di padre Bartolomeo Sorge La traversata-La Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi• sviluppa in oltre duecento intense pagine di gradevolissima lettura la riflessione di un testimone speciale, che ha transitato tra le più significative vicende di una stagione, che dall’indizione del Concilio Vaticano II (25/01/1959) ha registrato cambiamenti, attese ed anche momenti di affanno nel cammino della Chiesa.
Sacerdote della Congregazione dei Gesuiti, persona di riconosciuto spessore spirituale e culturale, esperto di dottrina sociale della Chiesa, padre Sorge ha diretto le riviste La Civiltà Cattolica dal 1973 al 1985, Popoli dal 1999 al 2005 e Aggiornamenti Sociali dal 1997 al 2009, ricevendo con le parole di padre Carlo Casalone S.J., Superiore Provinciale d’Italia, sempre vasto apprezzamento per le “riflessioni limpide e coraggiose, che hanno aiutato a orientarsi nella burrascosa stagione della vicenda politico-sociale del nostro Paese e della congiuntura internazionale in corso” .
Sorge sostiene che, giunti al “giro di boa” dei cinquant’anni dal Vaticano II, la rotta autenticamente innovativa del Concilio stessa non vada abbandonata. Anzi, i cambiamenti della società impongono di non deviare da quella linea, fedelmente e responsabilmente perseguita da alcuni infaticabili “traghettatori”, “uomini di Dio di cui oggi continuiamo ad avere particolare necessità, designati dalla Provvidenza e dalla storia ad accompagnare la Chiesa e la società nella difficile transizione dal secondo al terzo millennio” . Senza metafore egli afferma che “molti, infatti, vedono nella Chiesa-istituzione e nei suoi esponenti solo l’ambizione del potere, l’ostensione di un cristianesimo burocratico e ufficiale, lontano dal vero spirito del Vangelo. La Chiesa non si può ridurre a un apparato istituzionale, a una benemerita agenzia del buon soccorso, impegnata ad alleviare le sofferenze dei poveri; a una potenza politica che intrattiene rapporti diplomatici a livello internazionale; meritevole d’attenzione solo per la sua storia bimillenaria, per il suo patrimonio culturale o per il suo radicamento universale” . Tutto ciò svuoterebbe la vera missione della Chiesa.
La traversata ci conduce in anni non lontani e ci fa incontrare Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, padre Pedro Arrupe, Dom Hélder Câmara, monsignor Oscar Romero, monsignor Enrico Bartoletti, Giuseppe Lazzati, il cardinale Salvatore Pappalardo, don Pino Puglisi e il cardinale Carlo Maria Martini, testimoni di un tempo particolarmente problematico.
È un cinquantennio che i meno giovani conoscono, caratterizzato da significativi fatti politici e culturali di dimensioni nazionali e mondiali, dalla crescente affermazione della multimedialità, dall’ingresso di nuove parole, come secolarizzazione e globalizzazione, che hanno assunto particolare predominanza nel dibattito sul dualismo chiesa e società, dalla diffusa attenzione alle biotecnologie e ai temi cosiddetti eticamente sensibili (sessualità, inizio, fine vita, ecc.).
In questi decenni la Chiesa ha ravvisato la funzione dei laici, invitati ad esprimere un laicato maturo per “sostenere il dialogo interculturale alla ricerca di quell’ethos comune, di cui ha bisogno l’umanità in via di globalizzazione, nel rispetto del pluralismo e della laicità della politica, della cultura, delle arti, della scienza e della tecnica” . Il termine laicità “oggi ha acquistato una portata nuova, è compreso come condizione essenziale della necessaria collaborazione tra Stato e Chiesa in vista del bene comune” . È una concezione che esprime apertura e non divisione.
Già in occasione del quarantennale dall’apertura solenne del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962), certamente l’evento di maggiore risonanza della Chiesa del secolo scorso, Sorge evidenziava i mutamenti della realtà sociale, osservando che “il mondo è cambiato e si va globalizzando nel bene e nel male. Tante sfide hanno solo mutato volto: l'ateismo non è più quello scientifico marxista o materialista, ma è quello pratico del pensiero unico dominante; l'umanità non è più divisa dal muro di Berlino, ma dal muro della povertà e della fame, dell'egoismo e del razzismo; la minaccia della guerra atomica ha lasciato il posto a quella del terrorismo internazionale. Altre sfide, invece, sono nuove: il relativismo etico, seguito alla caduta delle ideologie e alla crisi dei valori; i flussi migratori crescenti e inarrestabili; le contraddizioni di una crescita economica, culturale e tecnologica che avvantaggia solo una minoranza dell'umanità” .
È opinione diffusa e condivisibile che con la grande assise ecumenica voluta da Giovanni XXIII la Chiesa abbia intrapreso un fiducioso itinerario di aggiornamento teologico e pastorale, dialogando con il mondo ed affrontando temi di assoluta rilevanza spirituale, sociale e morale.
La traversata è un meditato monitoraggio del tempo post-conciliare, che, di volta in volta, è stato rivissuto in quattro importanti convegni ecclesiali, di cui Sorge esplicita le motivazioni, le attese e i risultati. Indetti a significativa distanza tra di loro sono legati da un filo comune soprattutto nella ricorrente elaborazione del tema sulla valorizzazione della vocazione dei laici nella vita della Chiesa e della società.
Nel Convegno “Evangelizzazione e promozione umana” (Roma, 30 0ttobre-4 novembre 1976) la Chiesa guidata da Paolo VI si impegna “ad un ripensamento della sua missione nel mondo contemporaneo, ad una coscienza religiosa autentica e nuova, ad un confronto col vertiginoso mondo moderno” . La Chiesa ha la consapevolezza “di essere visibilmente in ritardo sul rapido evolversi della vita culturale e sociale del Paese” .
L’incontro romano si caratterizza per le ampie riflessioni sulle nuove forme di presenza politica dei cattolici, che nel documento conclusivo della Conferenza episcopale italiana viene teoricamente accolta nella formulazione del pluralismo, purché non in “contrasto con l'unità di fede e di comunione, e con quella visione dell'uomo e della società che scaturisce dal cristianesimo”.
Loreto è sede dal 9 al 13 aprile 1985 del secondo Convegno nazionale della Chiesa italiana Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, che vede Giovanni Paolo II imprimere la propria autorevolezza. Lo si vuole “un convegno itinerante e aperto, capace di creare una sensibilità pastorale comune tra i cattolici italiani, una maturazione delle coscienze, una convergenza nelle interpretazioni e negli impegni” . A Loreto si ricerca “una imponente rinascita morale e religiosa, capace di dare vita a una nuova eticità per trasmettere stimoli rigeneratori alla politica, e anche coinvolgere in una ripresa di impegno politico le giovani generazioni, oggi complessivamente disattente e spesso lontane da questo essenziale ambito della vita collettiva” .
Il dibattito verte, tra l’altro, sulle nuove forme di missionarietà, sulla scelta religiosa, sul dialogo fra le diverse culture, sulla presenza sociale della Chiesa e la formazione dei laici e sul rapporto fra i cattolici e la politica. “I cristiani mancherebbero - per il pontefice - ai loro compiti se non si impegnassero a far sì che le strutture sociali siano o tornino ad essere sempre più rispettose di quei valori etici, in cui si rispecchia la piena verità sull’uomo”. Per Giovanni Paolo II “la storia del movimento cattolico, fin dalle origini, è storia di impegno ecclesiale e di iniziative sociali che hanno gettato le basi per un’azione di ispirazione cristiana, anche nel campo propriamente politico, sotto la diretta responsabilità dei laici in quanto cittadini, tenendola ben distinta dall’impegno di apostolato, proprio delle associazioni cattoliche” .
Secondo la nota espressione di Paolo VI la politica deve proporsi come “la forma più alta ed esigente di carità” e tale concezione deve essere responsabilmente perseguita dai laici, tema che anche a Loreto è al centro di varie argomentazioni.
A proposito di carità, Sorge riprende nel suo libro il concetto di “carità di alto profilo” attribuito a Benedetto XVI. “La prima sarà sempre la carità verso i bisognosi, gli ammalati, gli emarginati; è la testimonianza, per così dire, classica e tradizionale. In secondo luogo, quale alta testimonianza di carità, Benedetto XVI cita anch’egli l’assunzione di responsabilità civili e politiche da parte dei fedeli laici” .
Il tema proposto al terzo Convegno ecclesiale, organizzato a Palermo dal 20 al 24 novembre 1995, ha per titolo Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia. Tra le linee preferenziali emergono la cultura, la politica, i poveri, la famiglia e i giovani. È un tempo che vede il nostro paese, anche a causa “dell’uso immaturo e improprio che è stato fatto del sistema maggioritario” politicamente spaccato in due con una “situazione ben lontana da quella riconciliazione cristiana e comunità degli uomini ipotizzata a Loreto” . La fine del collateralismo, già sostenuta da Paolo VI nell’indicare la “scelta religiosa”, quale missione fondamentale della Chiesa, la distanza fra piano religioso e politico, non giustificano comunque un atteggiamento di neutralità della chiesa italiana. Anche a Palermo ha vasta eco il vibrante discorso programmatico di Giovanni Paolo II sulla responsabilità dei credenti nei confronti della crisi. Il pontefice ammonisce che "non sempre è stata sufficientemente chiara e coerente la testimonianza di vita da essi offerta", poiché “il nostro non è il tempo della semplice conservazione dell'esistente, ma della missione” .
Il convegno non pronuncia un chiaro giudizio sulle differenti culture politiche sostenute dai cattolici. Sorge ricorda, a proposito, l’illuminata e illuminante posizione assunta dal cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini nel discorso per la festa di Sant’Ambrogio del 6 dicembre 1995, intitolato C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare, recuperando in quello storico intervento i temi richiamati da Giovanni Paolo II.
“La Chiesa non può, non deve parlare di leader o di partiti, né parteggiare per l'uno o per l'altro degli schieramenti politici; e questo a Palermo non l'ha fatto. Tuttavia la Chiesa non può tacere, non può non dare un giudizio morale sulle culture politiche, sui modelli sociali e sui programmi che si confrontano oggi in Italia. Non può essere equidistante o neutrale - puntualizza il cardinale Martini - nei confronti di un atteggiamento che contesta la funzione dello Stato nella tutela dei più deboli; di una logica decisionista che cerca di estorcere il consenso per via plebiscitaria (fondamentalismo politico); di un liberismo utilitaristico che fa del profitto, della efficienza e della competitività, un fine, a cui subordina le ragioni della solidarietà; di una politica che chiede deleghe del potere sulla base del successo del leader di turno più che sulla base di programmi coerenti ed efficaci; che si rifà a una logica conflittuale inaccettabile, secondo cui chi vince piglia tutto e chi perde è solo un nemico da eliminare” .
Dal 16 al 20 ottobre 2006 la Chiesa italiana si riunisce a Verona con papa Benedetto XVI. Comunione e corresponsabilità sono le grandi direttrici prese in esame ed ancora una volta, così si desume dalla relazione introduttiva del cardinale Dionigi Tettamanzi sul tema Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, il riferimento al laicato diventa lo snodo significativo per definire spazi e responsabilità dei laici. Tale obiettivo aveva già avuto visibilità in un documento di rilievo della Conferenza Episcopale Italiana del 1981, nel quale si affermava che i laici devono assicurare la loro testimonianza, in quanto “l'assenteismo, il rifugio nel privato, la delega in bianco non sono leciti a nessuno, ma per i cristiani sono peccato d’omissione” .
In ogni occasione emerge l’esigenza di consolidare nei fatti quel salto di qualità che, peraltro, è già spronato nella Gaudium et spes quando affronta la relazione fra la Chiesa e la comunità politica, “indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo” .
In una significativa parte del libro, la scrupolosa conoscenza dei fatti e l’affetto si fondono nel tracciare con precise puntualizzazioni e senza alcuna semplificazione i profili degli straordinari “traghettatori del Concilio” che hanno operato nel solco delineato da Giovanni XXIII per far conseguire allo “spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze” .
Sorge definisce Paolo VI, papa riformatore, amletico, persona “che soffriva di far soffrire gli altri ed essere felice di renderli felici”; Giovanni Paolo I, “timido, ma vivace; severo, ma arguto; sorridente, ma pensoso; Giovanni Paolo II, “traghettatore che ha accompagnato storicamente la Chiesa dal secondo al terzo millennio”, i cui 27 anni di pontificato non sono davvero riassumibili in poche battute; padre Pedro Arrupe, dal 1965 al 1983 Superiore generale della Compagnia di Gesù, “testimone profetico, rinnovatore, grande comunicatore, incompreso o mal compreso”; Dom Hélder Câmara, arcivescovo brasiliano di Olinda e Recife, che ha fatto della povertà “una scelta non ideologica, ma evangelica” adoperandosi per “una Chiesa povera e serva”; monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, “umile uomo di preghiera”, consapevole del suo martirio, sempre “fedelissimo alla Chiesa e al Papa”; monsignor Enrico Bartoletti, il protagonista del Convegno romano del 1976, sostenitore “di una Chiesa rinnovata, in atteggiamento di servizio e di dialogo, meno giuridica e più carismatica”; il professor Giuseppe Lazzati, straordinaria figura di cattolico “che si è battuto con tutte le forze per riaffermare il primato della dimensione morale nella costruzione della città dell’uomo”; il cardinale Salvatore Pappalardo, “guida soprattutto etica e culturale, oltre che spirituale” al centro di quella “Primavera di Palermo”, che traguardava “il riscatto della città dalla mafia e il recupero della legalità attraverso un modo nuovo di fare politica”; don Pino Puglisi, il coraggioso parroco del quartiere Brancaccio di Palermo assassinato dalla mafia nel 1993, perché, “la mafia non poteva tollerare l’amore con cui un sacerdote si dedicava a sottrarre i giovani alla strada e alla malavita”. Infine, il cardinale Carlo Maria Martini, il solo “traghettatore” vivente tra quelli menzionati nel libro. Sorge propone un’intervista rilasciata dal confratello nel 2002, a conclusione del suo servizio pastorale nel capoluogo lombardo. Non aggiungo nulla nell’affermare che emerge la statura dell’autorevole pastore, che “ha sempre creduto nella forza della ragione, in perfetta armonia con la sua fede”, auspicando “una Chiesa povera e umile, indipendente dai poteri del mondo”.
La traversata è il ritratto della Chiesa che in cinquant’anni ha tracciato non senza fatica un cammino spirituale ed esistenziale confrontandosi con le nuove e complesse sfide, che si sono presentate. Padre Bartolomeo Sorge rinuncia, comunque, al pessimismo nel rilevare, a conclusione della sua rispettabile analisi, che “la traversata sembra farsi ogni giorno più faticosa e difficile; ma questo non deve fare paura” .
Valerio P. Cremolini